SEBASTIANO ZANOLLI: ECCO COME FARE, CON (MOTIV)AZIONE, LA GRANDE DIFFERENZA

 «Io sono un manager, uno di quegli odiati o invidiati personaggi che passano la vita tra meeting e target, tra down-sizing e market share, tra presentazioni in power point e key account arrabbiati». Si presenta così, nel suo primo libro del 2003 («La grande differenza», Franco Angeli), Sebastiano Zanolli. Da allora sono cambiate molte cose. E infatti già scriveva: «La capacità di prevedere è senza dubbio una caratteristica dei grandi realizzatori», e specificava: «Non sto parlando di indovini o di lettura delle carte. Sto parlando dell’attitudine ad agire nel presente, avendo in mente il futuro». Citando Charles F. Kettering: «Tutti dovremmo preoccuparci del futuro, perché là dobbiamo passare il resto della nostra vita», personalmente scriverei: «Tutti dovremmo preoccuparci del futuro, perché là dobbiamo passare il resto del nostro presente».
«Io sono un manager, uno di quegli odiati o invidiati personaggi che passano la vita tra meeting e target, tra down-sizing e market share, tra presentazioni in power point e key account arrabbiati». Si presenta così, nel suo primo libro del 2003 («La grande differenza», Franco Angeli), Sebastiano Zanolli. Da allora sono cambiate molte cose. E infatti già scriveva: «La capacità di prevedere è senza dubbio una caratteristica dei grandi realizzatori», e specificava: «Non sto parlando di indovini o di lettura delle carte. Sto parlando dell’attitudine ad agire nel presente, avendo in mente il futuro». Citando Charles F. Kettering: «Tutti dovremmo preoccuparci del futuro, perché là dobbiamo passare il resto della nostra vita», personalmente scriverei: «Tutti dovremmo preoccuparci del futuro, perché là dobbiamo passare il resto del nostro presente».
Questo ha fatto Zanolli: si è talmente impegnato a comprendere come da un’azione oggi derivino le azioni di domani, come dall’autodisciplina scaturiscano risultati significativi, come dal benessere di un solo individuo derivi il benessere dell’azienda che lo impiega prima, dell’intera società dopo, che è divenuto uno «speaker motivazionale». Ante litteram: quando cominciò ad occuparsi di «motivare» (lui ci dirà, in questa intervista, che il suo obiettivo è «ispirare»), non esisteva la figura del «coach» o «counsellor», che tanto va di moda oggi. Ha precorso i tempi ed ora ispira gli ispiratori, motiva anche i motivatori. Lo paragonerei al suggeritore che è nascosto nel «gobbo» del palco, durante uno spettacolo in teatro. Colui che dice le battute giuste a chi le pronuncia dinnanzi alla platea.

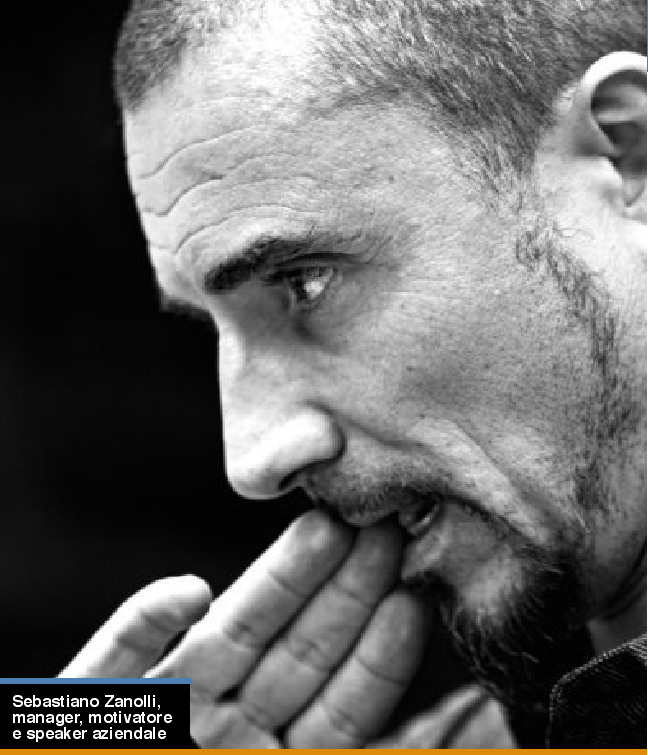
Zanolli è colui che spiega alle aziende – non alla persona giuridica ma alle persone fisiche che la compongono – «perché» e non «come» raggiungere gli obiettivi. E nella crisi che il mondo sta vivendo, la depressione economica affianca quella patologica a tal punto da non distinguersi più quale, tra le due, sia la causa e quale sia l’effetto. Così l’azienda chiama Zanolli, che da Bassano del Grappa arriva, intriso di energia veneta, e spiega come sviluppare il sistema reticolare attivante, meccanismo che scatta quando si decida a darsi un ordine attraverso la sua continua ripetizione nella nostra testa, in modo che il subconscio si programmi per realizzarlo, attivandosi ed accrescendo la sensibilità e la consapevolezza verso le idee e le persone.
Convinzione e connessioni, ecco la chiave, l’effetto leva della nostra motivazione. Zanolli lo sa.
LA VIDEOINTERVISTA
L’INTERVISTA
Domanda. Manager, scrittore e speaker motivazionale. Qual è stato il suo percorso di vita?
Risposta. Dopo aver preso la laurea in Economia e commercio ho cominciato a lavorare da subito come venditore, avendo per caso incontrato il titolare di un’azienda di tessuti che cercava un assistente che lo seguisse in giro per il mondo. Mi piaceva viaggiare, e dovevo imparare a proporre merce, cosa che io, essendo figlio di un artigiano, non avevo imparato. Avevo imparato però che funzione del benessere nella vita è il lavoro, e più si vuole più si deve lavorare. Entrato nel mondo delle vendite, mi resi conto che non era così, che il venditore non ha diritti, li ha il cliente, e a quel punto viene a mancare la connessione logica tra lavoro e risultati che è invece presente nel lavoro di un operaio. Cominciai così a confrontarmi con gli addetti ai lavori, rendendomi conto che la maggior parte di essi non sapeva darmi risposte, così decisi di scriverle io: nel 2003 uscì «La grande differenza», che ebbi la fortuna di pubblicare con la Franco Angeli attraverso un amico che mandò il mio manoscritto alla redazione. Il libro ha cominciato a vendere, quindi vendere bene, ed è ora un «long seller» da 24 ristampe. Ne sono nati argomenti di approfondimento.
D. Dove nasce l’azione?
R. C’è chi attende di far qualcosa che dia significato e che renda significativa la propria esistenza, ma non si mette in moto. Si deve muovere se stessi e muovere gli altri in relazione a risultati economici. Non a tutti interessa la connessione tra le azioni ed il risultato che devono ottenere. Ho riflettutto sulle galassie degli obiettivi personali: la paura, la presenza di altri che possono essere di supporto, la possibilità di essere a sua volta di aiuto, le reti di direzione, tutti temi relativi al «marchio personale», non alla persona ma al personaggio. Avevo notato che, mentre nell’aspetto esistenziale si è persone ed è importante essere significativi per se stessi, nel gioco sociale di mercato e liberista vale il personaggio, la sovrastruttura che si crea attorno alla propria persona. Mi sono accorto che ci sono personaggi che possono portare a casa risultati senza essere persone, e persone che non essendo personaggi non riescono a portare a casa risultati. Vincent Van Gogh e Pablo Picasso sono due esempi speculari: uno muore povero, l’altro riesce a sfondare in vita. Non voglio soffermarmi troppo sul tema della ricchezza, ma come manager l’aspetto del risultato economico resta importante: negare che il benessere materiale sia una cosa cui ambiamo, non fosse altro che per mantenere i genitori anziani, è impossibile. Ho scritto molti altri libri, ed hanno ampliato la mia superficie di contatto con il pubblico non aziendale mentre continuavo a fare il manager in azienda. I miei libri mi hanno fatto promozione e le aziende hanno cominciato a chiamarmi per fare delle consulenze. Così è nato questo lavoro. Ed ho la fortuna di avere grande passione per una materia per cui il mercato è disponibile a pagare.
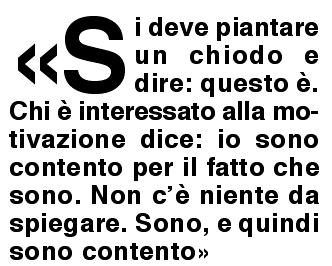
D. Chi la cerca?
R. Mi chiamano per la formazione in aula o all’interno di kermesse. In quest’ultimo caso, è richiesto un intervento più mirato che è racchiuso in un tempo breve, teso a motivare istantaneamente.
D. In cosa consiste il suo lavoro da manager, e come si affianca alla strada parallela dello «speech» aziendale?
R. Il mio lavoro consiste nel fare «employer branding», quelle attività utili a tenere lucido il marchio dell’azienda non tanto nei confronti dei consumatori, cui pensa il reparto del marketing, bensì nei confronti degli attori che hanno a che fare con il marchio da fuori, quindi università, organizzazioni, enti politici, Comuni, ossia coloro che devono avere una buona idea del marchio, inclusi i dipendenti, i talenti e le persone che escono dalle università ed aspirano ad un luogo di lavoro come quello che l’azienda offre. Mi occupo dell’aspetto qualitativo dell’organizzazione, non tanto per i consumatori quando dal punto di vista del benessere dei lavoratori, coinvolgendo il tema dell’attrattività dell’azienda per uno studente che vuole crescere. Al di là del fattore economico, lo studente che si affaccia sul mercato si pone questa domanda: qual’è l’azienda in cui si sta meglio, che mi farà crescere di più, che mi arricchirà? Tale lavoro si sposa molto bene con i temi del facilitatore, anche se spesso mi definiscono un «motivatore» o un «coach»; non che io mi ribelli a queste definizioni, sono solo più semplici.

D. È davvero possibile «motivare» con un discorso o con un libro?
R. Il motivatore presume di entrare in un posto ed uscirne dopo aver motivato le persone che lo hanno ascoltato. Nella mia esperienza non ho mai visto nessuno motivare qualcun altro: ho visto qualcuno «ispirare» qualcun altro. La motivazione è sempre frutto di ragionamento, di un sentimento interno. Si può preparare la tavola, sistemare il fiore, poi è il meccanismo che si sviluppa all’interno della persona che deve mangiarvi a farle apprezzare il contesto e scegliere tra un ristorante e l’altro. Una motivazione sorta per il solo fatto di aver ascoltato uno «speech» è una motivazione di breve durata, come camminare sui carboni ardenti. Possiamo lasciarci ispirare, ma la motivazione è più sofisticata.
D. La sua storia da «ispiratore» è iniziata in un momento in cui non era troppo in uso del resto, e figure simili non esistevano. Ora può essere l’ispiratore degli ispiratori, mentre prima non aveva qualcuno cui ispirarsi e da cui, in seconda facie, essere motivato.
R. Vero. Questo è importante. Mi citano nelle tesi, mi cercano. Il fatto di essere partito in un momento in cui il mercato non presentava tale offerta mi ha consentito di fare quello che faccio e di dedicarmi ad entità plurime, creando relazioni costruttive: infatti, lavorando con le persone sulla loro motivazione e in modo accorto ed onesto, è difficile che non si sviluppino buoni rapporti. Questo fattore apre un altro ventaglio di possibilità. Anche l’online si avvale delle raccomandazioni degli altri; il «feedback», che è frutto di un’esperienza e di una relazione, è sempre più importante. Credo molto nello strumento delle relazioni, e va trattato con cura perché la linea che c’è tra il raccomandare chi è meritevole e la malversazione è sottile, e la fa da padrona la morale che ciascuno di noi sposa.
D. La democrazia di internet dà più manforte alla lealtà di queste relazioni, contrastando una forma di favoritismo verso amici attraverso il «feedback»?
R. C’è assolutamente più trasparenza.
D. In un momento di economia stagnante e di «low profile», come «ispirerebbe» un’azienda depressa, in senso economico ed in senso psicologico, che deve trovare delle basi in un mondo di altre aziende che si trovano nella medesima condizione?
R. Per me non esiste l’azienda, mi riferisco sempre alle persone all’interno della stessa. Quando mi chiamiamo a fare interventi di tipo motivazionale, ossia che serva a cambiare stato alle persone, suggerisco di valutare l’obiettivo: crearne uno interessante fa nascere spontaneamente una motivazione. Il problema sorge quando l’azienda ha un obiettivo che il lavoratore non avverte come proprio, o non capisce. La prima dice al secondo come deve cambiare per spostarsi da un punto A ad un punto B; cambiare, per la base aziendale coincide con un maggior carico di lavoro, una maggiore flessibilità, velocità aumentata, non sempre un aumento di stipendio. Il «motivatore» deve dimostrare come l’obiettivo che l’azienda si pone in un dato momento costituisca una tappa fondamentale per arrivare all’obiettivo specifico dei singoli individui. Ossia: perché il lavoratore sia soddisfatto, si deve per forza passare per la soddisfazione aziendale. In questo modo e con tale consapevolezza si crea motivazione nel singolo.

D. Nella maggior parte dei casi, però, l’obiettivo che motiva il lavoratore si semplifica in un solo elemento: la retribuzione.
R. Questo, in un’economia stagnante, è molto limitante. Per qualche motivo l’azienda potrebbe non avere la capacità di pagare di più, ma a conti fatti quello che diciamo è una mezza verità: la gente non è motivata dallo stipendio. O meglio, il congruo stipendio è senza dubbio un fattore igienico, ma dopo alcuni mesi dall’aumento della remunerazione, questo non fornisce già più la motivazione che ne era alla base. Ciò non vuol dire che non si debba pagare i dipendenti, tutt’altro; ma se si pensa di poter motivare i singoli solamente con i soldi si sbaglia. Senza considerare che a volte l’azienda non può nemmeno farlo, e spesso deve addirittura tagliare in quanto carente di risorse adeguate. Il lavoro da fare in questo caso verte sempre sul significato: domandare il senso di ciò che il lavoratore sta facendo. In che modo sarà differente? Come sarà migliore una volta entrato nel percorso di cambiamento proposto dall’azienda? Questo passaggio, che non è affatto semplice, avviene attraverso un ragionamento che va fatto con i singoli, riflettendo sui loro obiettivi, mettendo poi sullo stesso tavolo la direzione dell’azienda e la direzione individuale. Quando, attraverso ragionamenti che in parte sono di pancia e in parte di testa, si riesce ad allineare i due cerchi azienda-individuo e a creare un’intersezione sempre maggiore, è lì che scatta la motivazione: esattamente là dove il cerchio della testa (fare qualcosa perché conviene) e il cerchio della pancia (fare qualcosa perché piace) sono il più sovapposti possibile. Grazie a questa congruenza, il sacrificio non è più tale e vissuto negativamente. Questo capita a pochi, fortunati personaggi. Possiamo sperare che una piccola intersezione tra i due cerchi ci sia. Il mio lavoro è quello di cercare di allargarla il più possibile soprattutto dove emozione e pensiero non coincidono: per uno stilista è più probabile che ciò che piace coincida con ciò che conviene, per chi produce bulloni tale congruenza non è tanto immediata, se tutta la giornata lavora sulla pressa. Ci sono impieghi in cui tutto ciò che vale è: «Dammi i miei mille, prendi le mie 8 ore», ma non sono quelli che auspichiamo per i nostri figli, auguriandoci per loro un lavoro che riempia anche il cuore oltre alla tasca e alla testa. Vengo di solito chiamato, in realtà, a parlare in ambiti nei quali le mansioni non sono così acri: per pulire degli uffici non si chiede motivazione di solito.
D. Per chi zappa la terra, paradossalmente, potrebbe esserci molto più cuore. Più è grande la struttura, meno è motivante la mansione – mi viene in mente la rivoluzione industriale, ancor di più il film di Charlie Chaplin «Tempi moderni».
R. La sfida che hanno strutture aziendali è proprio quella di tenere motivate le persone, e sono imprescindibili alcuni meccanismi fondamentali, primo tra tutti l’ascolto delle persone, che sempre dicono cosa vorrebbero essere o vorrebbero avere. È evidente che una economicità è richiesta e non dico che bisogna ascoltare tutti, ma non dico nemmeno che non bisogna ascoltare nessuno. Questo dipende dalla volontà di chi ha in mano le leve organizzative: se è in grado di allineare gli interessi aziendali con quelli individuali, l’azienda ha vinto.

D. Diverso è il caso delle strutture pubbliche?
R. Sì. Quando lo statale ha una totale assenza di motivazione, come è noto, è perché è troppo grande la distanza tra il senso del lavoro ed il suo svolgimento: nessuno capisce più perché sta apponendo un timbro su un foglio, e nessuno chiede più nemmeno se sia stato fatto, con conseguente deresponsabilizzazione e demotivazione. Quando non c’è un perché, nessuna cosa è motivante, ma questo è un problema del sistema. Nel pubblico, essendo storicamente mancati i controlli necessari, tale problematica si è diffusa di più.
D. Com’è cambiato, negli anni, il senso di apartenenza ad un’azienda?
R. Il più grande cambiamento è stato quello provocato da internet, con l’accesso alla conoscenza generale in qualunque momento. Ciò vuol dire anche che qualunque cosa si conosca in un dato momento è irrilevante, motivo per cui i giovani non danno più peso alle competenze del professore e, di riflesso, al professore stesso. Cosa resta? Bisogna investire nella capacità di fare connessioni, che è ancora appannaggio degli umani e non delle macchine. Se si ha un lavoro che non ha bisogno di connessioni, il livello minimo di salario è in effetti determinato dalla disperazione degli operatori; in un lavoro di tipo euristico-creativo, la capacità fondamentale è quella di inventare cose e connessioni per creare, attraverso una sintesi, qualcosa di importante.
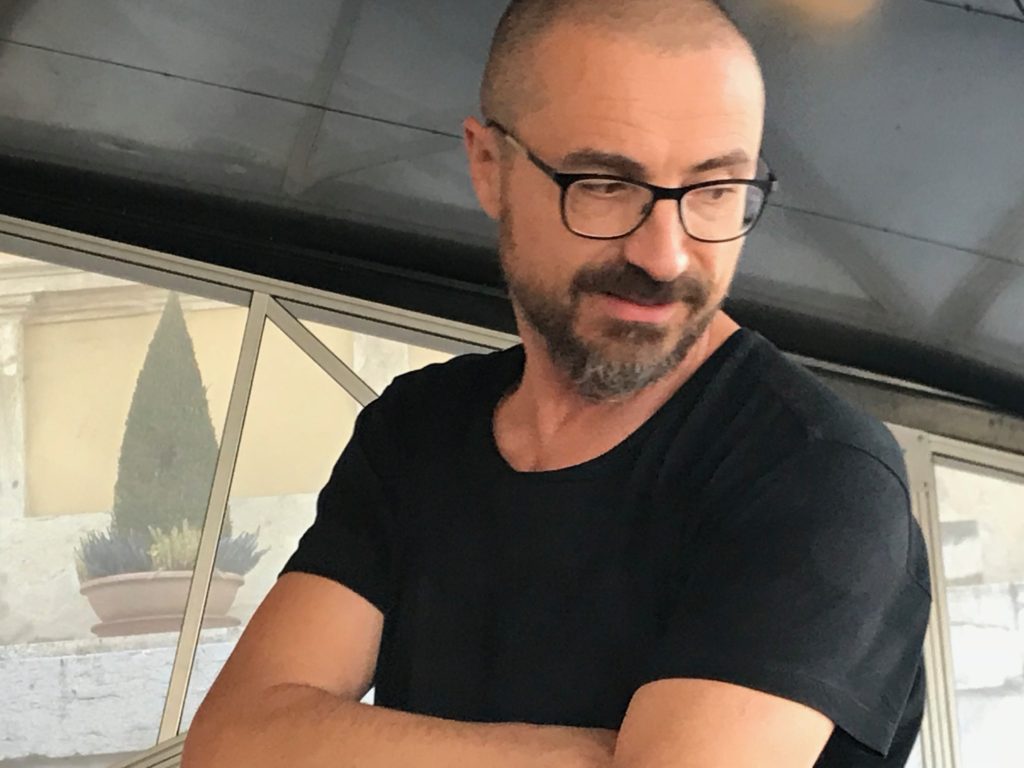

D. In realtà la motivazione serve non solo per fare il lavoro del «bullone», ma anche per il creativo che, a maggior ragione, ha bisogno di ispirazione e non di meccanicità.
R. Dipende sempre dall’intelligenza con cui si affronta la vita. Non è strano che si sia demotivati se si adotta un approccio statico, ossia si rinuncia alla curiosità.
D. Il punto è che la curiosità, a volte, è come la bellezza: o si è belli o si è brutti. È nel Dna. Poi, e solo in seguito, diviene una questione soggettiva, per cui ad alcuni sembra bello qualcosa che per altri non lo è. Ma alla base si hanno categorie che possono applicarsi sin dalla genesi. La curiosità non fa parte di queste?
R. È vero che la bellezza va comunque aiutata e mantenuta, ed è così anche per la curiosità.
D. Ma in questo caso, quello della curiosità, c’è anche una sorta di «metapensiero»: bisognerebbe avere la curiosità di essere curiosi per divenirlo.
R. C’è un motivo fondamentale per cui dovremmo comunque dare significato: il mondo funziona a partire dai nostri bisogni base, che crediamo di aver colmato, e in quanto già soddisfatti in via generale pensiamo di dover partire da questo livello superiore senza far più riferimento ai bisogni base. Tanti si sono dati da fare, ma se domattina il mondo smettesse di produrre energia elettrica, saremmo da capo.
D. Ossia, bisognerebbe far capire che se siamo demotivati tutti, ci fermiamo tutti. E che non possiamo demotivarci a turno, per far proseguire il mondo.
R. Esattamente. Alla fine, il punto chiave è quello degli esistenzialisti: che senso ha la vita? Da un punto di vista tecnico nessuno: si viene al mondo, poi si muore.
D. Il motivatore non è il primo esistenzialista, che si è dovuto motivare?
R. Lo è per forza di cose. Si deve piantare un chiodo e dire: questo è. Chi è interessato alla motivazione dice: io sono contento per il fatto che sono. Non c’è niente da spiegare. Sono, e quindi sono contento. E da lì si parte a dare un continuo significato in una storia che è la nostra e che noi stessi ci raccontiamo. Ma essa è vera? Non ha rilevanza che lo sia: gli avvenimenti di una storia sono oggettivi, il significato lo assumono nel momento in cui vengono messi all’interno di una relazione da parte del narratore. È proprio lì il lavoro: dare senso a qualcosa che senso non ha. (ROMINA CIUFFA)


GALLERY
































