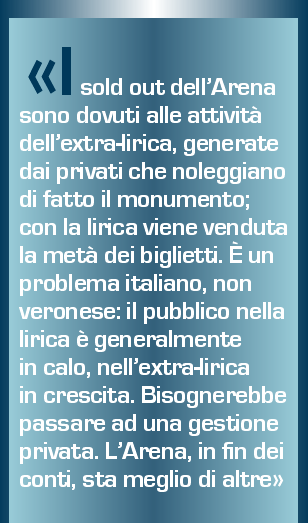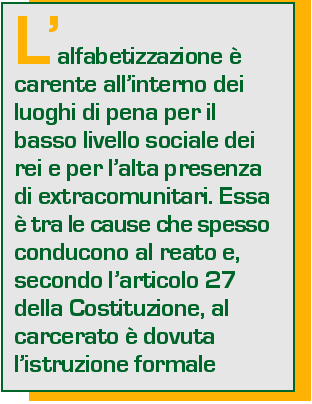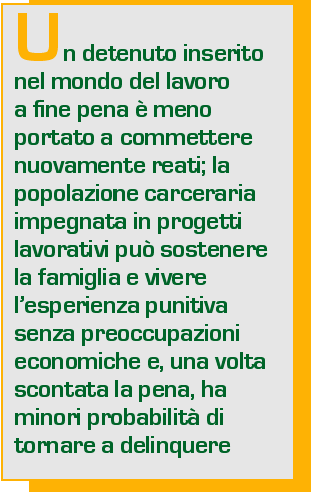FURIO HONSELL: DA UDINE ALLA REGIONE, I DIRITTI CIVILI NEL PATRIMONIO FRIULIANO

LA VIDEOINTERVISTA
 A circa 20 chilometri dalla Slovenia, 100 dall’Austria, 150 dalla Croazia, di certo Udine è più vicina all’est europeo che non all’Italia. In molti sensi. E nonostante potrebbe fregiarsi di un senso quasi «padano», nordico, per la sua altitudine, ricchezza, posizione, e rivendicare più di altre Regioni italiane la distanza da Roma, in senso politico, è una città di integrazione e di diritti civili. Per definizione. Sarà, il fatto che il Friuli-Venezia Giulia ha già uno Statuto speciale, dunque autonomia ed esperienza; sarà che in questi ultimi 10 anni è stata retta da un sindaco di centro-sinistra; sarà che l’identità friuliana non si misura sulla carta ma sul campo, e che esiste una lunga storia di emigrazione ed immigrazione che vede Udine attiva (ne sono testimoni i «fogolâr furlans», associazioni di friuliani nel mondo); sarà la coabitazione con l’Europa, quella del nord e dell’est.
A circa 20 chilometri dalla Slovenia, 100 dall’Austria, 150 dalla Croazia, di certo Udine è più vicina all’est europeo che non all’Italia. In molti sensi. E nonostante potrebbe fregiarsi di un senso quasi «padano», nordico, per la sua altitudine, ricchezza, posizione, e rivendicare più di altre Regioni italiane la distanza da Roma, in senso politico, è una città di integrazione e di diritti civili. Per definizione. Sarà, il fatto che il Friuli-Venezia Giulia ha già uno Statuto speciale, dunque autonomia ed esperienza; sarà che in questi ultimi 10 anni è stata retta da un sindaco di centro-sinistra; sarà che l’identità friuliana non si misura sulla carta ma sul campo, e che esiste una lunga storia di emigrazione ed immigrazione che vede Udine attiva (ne sono testimoni i «fogolâr furlans», associazioni di friuliani nel mondo); sarà la coabitazione con l’Europa, quella del nord e dell’est.
Sarà tutto questo, ma di certo Udine risulta – anche dopo il terremoto del 1976 (scosse a maggio e a settembre) che vide lì proprio il suo epicentro – florida. La ricostruzione fu rapida e completa e subito, a due giorni dal sisma, il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia stanziò con effetto immediato 10 miliardi di lire. Il modo in cui venne gestito il dramma è ancora alto esempio di efficienza.
I dieci anni per il doppio mandato dell’attuale sindaco Furio Honsell stanno per terminare: dal 28 aprile 2008 al 31 dicembre 2017 la città, che ha appena ospitato al Festival Mimesis i più grandi filosofi e pensatori italiani, è uno dei capoluoghi italiani dei diritti civili anche grazie a lui. Il caso di Eluana Englaro, costretta 17 anni in stato vegetativo per accanimento terapeutico; le unioni civili (è di Honsell la trascrizione del matrimonio di Adele Palmieri e Ingrid Owen prima che ci fosse una legge ad hoc), la protesta dei quattro dipendenti della Gros Market di Pradamano (sul tetto è salito anche il sindaco), l’accoglienza dei rifugiati e dei vicini di casa. Honsell, nato a Genova, già rettore dell’Università di Udine, matematico e rigoroso scientifico, ora è pronto per la sfida alle regionali.

D. Da Genova a Udine: che percorso l’ha portata in Friuli?
R. Sono arrivato la prima volta a Udine da studente universitario in autostop, poi da professore con un concorso nazionale. La mia prima lezione si è svolta nel lontano anno accademico 1988-1989. All’epoca era un’università molto giovane, e per non disturbare quelle limitrofe l’avevano obbligata ad avere dei corsi allora considerati secondari: Informatica, Conservazione dei beni culturali, Agraria. Questo la dice lunga su quanto sia difficile prevedere il mondo. Sono stato rettore dal 2001 al 2008, anno in cui mi sono dimesso; solo dopo mi sono candidato come sindaco. Da rettore ho conosciuto molto del territorio sotto tantissimi profili. Sono stato il propugnatore, tra la fine del secolo scorso e l’inizio di questo millennio, di quella che è stata chiamata la terza missione dell’università: il servizio al territorio, posto che la prima fu quella meramente didattica, e la seconda, con Friedrich Wilhelm Von Humboldt agli inizi dell’Ottocento, di ricerca. Quando mi sono candidato, l’ho fatto con la lista civica di sinistra Innovare con Honsell.
D. Due mandati, questo giunge al termine. Quali i suoi riferimenti in questi 10 anni?
R. Innanzitutto ho firmato il patto dei sindaci 202020 nel 2009. Esso prevede l’abbattimento del 20 per cento delle emissioni di CO2 da fonti fossili, l’aumento della percentuale energetica da fonti rinnovabili e l’efficientamento, quindi la riduzione dei consumi energetici del 20 per cento. Mi sono ispirato molto alla sostenibilità ambientale. I 17 SDG, «sustainable development goals» delle Nazioni Unite, prima ancora che li facessero, erano nella mia visione. Una delle cose delle quali sono più orgoglioso è che da rettore si progettò un grande sistema di cogenerazione di energia elettrica e calore in ospedale, con un sistema di raccolta e di ritrasferimento, attraverso un sistema di teleriscaldamento, a tutta la città: sono dovuto diventare sindaco per varare questo tipo di servizio pubblico. Oggi abbiamo diversi edifici, tra cui il Palamostre, riscaldati con calore che altrimenti andrebbe sprecato.

D. Udine è più «sostenibile» ora?
R. C’è tutto uno spettro di iniziative, inclusa l’illuminazione a led di tutta Udine. Quindi, una cosa che poche città hanno è il regolamento edilizio obbligatorio, che io ho varato per far sì che l’involucro di un edificio non abbia dispersione termica. Altra stella polare è l’essere parte della rete europea «healthy cities», città sane, dell’Organizzazione mondiale della sanità; siamo sempre stati la città di riferimento nella promozione degli stili di vita sani e della salute, intesa come benessere dei cittadini non solo fisico ma anche emotivo e relazionale.
D. È stato (ed è) anche un sindaco innovativo, non senza ricevere polemiche. Dalle unioni civili all’eutanasia.
R. Una delle cose che deve fare un sindaco è dare forza a chi ha buone idee. In città ci sono 100 mila abitanti e con l’unione dei Comuni stiamo arrivando a 150 mila. Pensi ad esempio ai matrimoni: ci sono quelli in fin di vita, quelli in carcere, ci sono le unioni civili per le quali mi sono battuto molto avendo avuto anche conflitti con il prefetto. Ho registrato una delle prime, e quando è passata la legge abbiamo fatto sì che non ci fosse discriminazione. Molte sono state le situazioni anche non previste dove si è dovuto fermamente difendere i diritti civili, ad esempio quando nella casa di riposo «La Quiete» abbiamo reso giustizia a Beppino Englaro, padre di Eluana, sottoposta per anni ad alimentazione forzata.
D. Un suo commento sull’eutanasia?
R. Parlo di diritto alla giustizia. Se legge la sentenza della Corte di appello avrà le lacrime agli occhi, ma non dubbi: non di eutanasia si è trattato, ossia procurare la morte in modo razionale o socratico, né di accanimento terapeutico, ma dell’articolo della Costituzione che dice che si possono rifiutare le cure. Chiamai il presidente Napolitano per chiedergli di non firmare la legge che gli stava passando Berlusconi perché illegittima, e mi disse che non lo avrebbe fatto.

Beppino Englaro con una foto della figlia Eluana
D. In Friuli è molto vivo il tema dell’immigrazione e dei richiedenti asilo, considerato anche il territorio. Come lo ha affrontato?
R. Abbiamo vissuto negli ultimi 5 anni un arrivo massiccio di coloro che il sud Italia ha mandato al nord e di quelli provenienti da altri luoghi, come Pakistan o Afghanistan, con picchi di duemila persone; ora siamo a circa mille. Non ho mai rifiutato: abbiamo mantenuto un alto livello di civiltà dando ospitalità a tutti in modo anche autonomo, considerato che il Governo di allora li lasciava in giro nel periodo in cui dovevano fare i documenti. Non solo li ho ospitati nelle palestre, nelle tende, nei parchi, ora 350 vivono in appartamenti e con la Croce Rossa abbiamo avviato l’apertura a tali fini di alcune caserme chiuse. Ad Udine spiccano ora romeni in primis, poi albanesi, quindi ghanesi. Questi ultimi sono stati sostituiti dalle ucraine, per via del lavoro da badanti: abbiamo un indice di vecchiaia di 218, ossia ogni 100 under 14 abbiamo 218 over 65. Udine conta 100 mila abitanti e degli 800 bambini nati lo scorso anno la metà ha genitori stranieri. L’età media degli udinesi è di 47 anni, ma se togliamo gli stranieri va ben oltre i 50. Ecco perché bisogna integrare gli stranieri, è questa la grande sfida. Abbiamo in Friuli 110 chilometri quadrati di aree militari dismesse, su 400 siti. L’intera superficie di Udine copre 56 chilometri quadrati. Perciò alcune caserme, come la Cavarzerani, sono state recuperate per i richiedenti asilo. Quando è in gioco questo tema, si fa appello ad aspetti umorali e superficiali; bisognerebbe invece pianificare in che modo promuovere l’inclusione sociale. Noi l’abbiamo fatto perché è tra i valori della città, e correlato c’è quello dell’equità. Quarto degli obiettivi europei di sviluppo sostenibile e uno degli aspetti più delicati dell’attuale coesistenza civile è proprio quello della disparità economica e sociale.

D. Un decennio di cambiamento, dunque, e accrescimento?
R. Ho fatto piantare in città anche il «ginkgo biloba», un albero importante: pochi sanno che è il primo che crebbe, spontaneamente, ad Hiroshima, quando tutto era stato raso al suolo. Questo è il significato del mio mandato. Non so se Udine è cresciuta con me, senz’altro mi auguro di non averla danneggiata. Quando incontro qualcuno che mi dice che sono il peggior sindaco dal dopoguerra – ogni tanto capita – rispondo sempre: «Aspetti di vedere il prossimo». La critica c’è sempre. Una delle sindromi psicologiche più comune è quella dell’availability bias: i cittadini ritengono più importante ciò che è più disponibile, quindi chiedono di chiudere le buche nelle strade. Ma quando l’ho fatto, mi hanno nuovamente interpellato perché, senza buche, le auto correvano troppo ed erano divenute pericolose. In compenso, ho rifatto le palestre nelle scuole perché bambini e atleti non abbiano cemento sotto ai piedi ma una superficie assorbente atta a non creare lesioni.
D. Udine e l’Europa: cosa c’è?
R. Innanzitutto ci sono la reputazione ed il prestigio che i friulani hanno nel mondo; inoltre ci sono i «fogolâr furlans» che consentono di trovare friulani ovunque. C’è anche l’Udinese, un forte veicolo dell’identità friulana (una delle più antiche d’Italia essendo nata nel 1896, ndr): ho rifatto lo stadio vendendolo, sa che mi costava più di un milione l’anno per tenerlo ai vertici richiesti dalla Uefa? Ora è dell’Udinese per 99 anni.

D. E gli udinesi si sono lamentati del cambio di nome, non più Stadio Friuli ma Dacia Arena: l’Udinese Calcio spa ha imposto la denominazione commerciale cedendo il «naming right» alla casa automobilistica rumena.
R. Avrei fatto un contratto di «naming», i consiglieri comunali non l’hanno voluto fare. E pazienza.
D. Si è sentita la crisi ad Udine e, più in generale, in Friuli?
R. Sono divenuto sindaco quando in Italia è iniziata la recessione economica, ma con certe operazioni siamo riusciti a compensare le minori entrate. Per esempio, con il led la spesa per l’illuminazione pubblica è scesa da 3 a 1,8 milioni, così come la spesa per il riscaldamento degli edifici pubblici è scesa da 3 a 1,2 milioni l’anno. La recessione ha colpito soprattutto i settori maturi e quelle aziende che non controllavano la filiera ma erano subfornitori per qualcun altro. Chi aveva una forte internazionalizzazione e il controllo della filiera produttiva è andato molto bene, chi vendeva il made in Italy all’estero non ne ha sofferto, chi faceva componentistica in molti casi è fallito. Deve pensare che in Friuli abbiamo avuto sempre diaspora e immigrazione, fino ad un fatto che si pensava fosse la fine di tutto e invece non lo è stato, il terremoto: poteva essere il colpo di grazia, ma è stata una scintilla. Abbiamo avuto un rinascimento e siamo diventati terra di immigrazione, fino al 2008. La stessa università è nata per il terremoto. Si diceva che il Friuli dovesse uscir fuori dal terremoto con la testa, ossia con l’università, alla maniera dei vivi, che sono tirati fuori dalle macerie dal capo, e non dai piedi, ossia con una nuova emigrazione, alla maniera dei morti. (ROMINA CIUFFA)

Romina Ciuffa, Loggia del Lionello (Udine)
GALLERY (photo ROMINA CIUFFA)
- Romina Ciuffa, Loggia del Lionello (Udine)



















 Capuleti e Montecchi, il clima a Verona è simile. L’amore non c’entra. Un nuovo sindaco da giugno, Federico Sboarina, e qui con me l’uscito, Flavio Tosi, che è stato primo cittadino per 10 anni rendendo la città una capitale d’Europa. I temi che affrontiamo con chi ha governato la città degli innamorati, della lirica, del marmo, dello Spritz, sono quelli dell’agognata (ma quanto?) autonomia del Veneto, degli scontri politici in seno alle divisioni del centrodestra, delle opere da realizzare o realizzate a Verona, della crisi dell’Arena (è del 16 ottobre l’incontro tra il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini e Sboarina che ha sancito la fine del commissariamento. Tosi riassume l’accaduto degli ultimi anni: «Una pessima figura internazionale), della revoca del project financing per risollevare l’ex Arsenale austriaco «Franz Josef I» che da tempo attende una riqualificazione, del tema del degrado e dell’insicurezza balzato di recente alle cronache.
Capuleti e Montecchi, il clima a Verona è simile. L’amore non c’entra. Un nuovo sindaco da giugno, Federico Sboarina, e qui con me l’uscito, Flavio Tosi, che è stato primo cittadino per 10 anni rendendo la città una capitale d’Europa. I temi che affrontiamo con chi ha governato la città degli innamorati, della lirica, del marmo, dello Spritz, sono quelli dell’agognata (ma quanto?) autonomia del Veneto, degli scontri politici in seno alle divisioni del centrodestra, delle opere da realizzare o realizzate a Verona, della crisi dell’Arena (è del 16 ottobre l’incontro tra il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini e Sboarina che ha sancito la fine del commissariamento. Tosi riassume l’accaduto degli ultimi anni: «Una pessima figura internazionale), della revoca del project financing per risollevare l’ex Arsenale austriaco «Franz Josef I» che da tempo attende una riqualificazione, del tema del degrado e dell’insicurezza balzato di recente alle cronache.