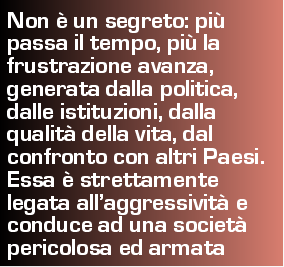TRANSESSUALISMO: L’INTERVISTA A UN’EX DONNA OGGI UOMO BISEX E A UN EX UOMO OGGI LESBICA

L’intervista di Romina Ciuffa ai trans Davide e Mirella (su Panorama). Davide era femmina, amava le femmine, oggi è maschio bisex. Mirella, ex ragazzo etero, è lesbica.
Anche su www.archivio.panorama.it/archivio/Tra-uomini-e-donne-non-ci-sono-confini e, alla fine dell’articolo, la versione del cartaceo originale
Impegnata nel sociale, giornalista corrispondente da New York per Panorama, scrissi nel 2006 questa doppia intervista nella quale confrontai i punti di vista di due transessuali: una donna divenuta uomo ed un uomo divenuto donna. A quei tempi non v’era comunicazione sul tema e le lotte, faticose, hanno condotto a miglioramenti nel campo LGBT. Le parole contenute in questo mio lavoro aiutano a comprendere meglio la differenza tra orientamento di gender e orientamento sessuale, che fanno sì che una donna che diventi uomo preferisca spesso intrattenere relazioni con un altro uomo e, dall’altro lato, un uomo che transizioni in una donna finisca per divenire lesbica. Inoltre, dà diretta compiutezza del morboso e sofferente senso identitario di taluni di sentirsi nati in un corpo sbagliato (ultimo film uscito in proposito, “3 Generations“), che gli psichiatri classificano come disturbo dell’identità di genere (spesso abbreviato in DIG), rinominato disforia di genere nel DSM5 (la versione più recente del Manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali), una condizione in cui si ha una forte e persistente identificazione nel sesso opposto a quello biologico. Viene definito “transessuale” ai fini del cambio di sesso solo chi non ha psicopatologia associata: chi non ha un disturbo mentale. È ovvio che, nel caso di una depressione associata o disturbi alimentari, molto frequenti, o altro, questi possano essere derivati dalla condizione del DIG, ossia dalle esperienze negative connesse a tale problematica ma non intrinseche ad essa. Il termine disforia di genere venne introdotto nel 1971 da Donald Laub e Norman Fisk. È poi possibile che la sintomatologia psichiatrica dei soggetti DIG sia conseguenza di un PTSD (Disturbo post-traumatico da Stress) conseguenti a violenze sessuali subite o comunque legate a pregiudizi e atteggiamenti negativi verso le persone con varianze di genere. Questo tipo di esperienze traumatiche sono molto frequenti in tale popolazione Il DIG può comunque mascherare rilevanti problemi psichiatrici. Infine, anche il disturbo di dismorfismo corporeo è associato al DIG, benché inserito tra i disturbi facenti parte dello spettro del “Disturbo ossessivo complusivo e disturbi correlati”. In questa doppia intervista, pubblicata su Panorama, ascolto solo loro, non la società né la psichiatria.
Lui è nato femmina, ha sempre amato le donne, poi è diventato uomo, ora è bisessuale. Lei è nata maschio eterosessuale con esperienze omosessuali, poi ha avuto una parentesi come donna etero e adesso è lesbica. Sono Davide Tolu e Mirella Izzo. Il primo, autore dello spettacolo teatrale One New Man Show in tour per l’Italia, scrittore, portavoce del Coordinamento nazionale Ftm (femmine transizionanti maschio), solo da 12 anni è fisicamente uomo, dice: «Se non fossi riuscito a operarmi, mi sarei ucciso. Detestavo talmente quelle parti femminili che m’impedivano di essere me stesso che me le sarei amputate». La seconda, Mtf (maschio transizionante femmina), presidentessa onoraria di Crisalide azioneTrans, ex dipendente di Poste italiane e varie cariche sindacali, si definisce «diamante»: «Perché non transizioni e non sopravvivi se non impari a essere dura».
Esiste un sesso intermedio?
Davide. In natura il confine tra i due sessi non è netto: il transessualismo è un fenomeno naturale in alcune specie di animali, così come l’ermafroditismo. Se nella specie umana il cambio di sesso non avviene spontaneamente, esistono però vari generi intermedi come l’intersessualismo e lo pseudoermafroditismo. È di scoperta recente l’esistenza di maschi che hanno patrimonio genetico femminile: si sono sviluppati come uomini anche se erano XX per una disfunzione genetica. Sono sterili, ma non hanno alcun problema di salute. Un’altra stoccata della natura alla presunzione umana di voler etichettare tutto prima ancora di conoscere.
Mirella. Non uno, ma esistono più sessi intermedi e orientamenti sessuali misti. La quasi totalità degli animali esprime comportamenti omosessuali a eccezione che nei periodi riproduttivi. La Chiesa continua a considerare gay e trans contro natura, mentre leoni e leonesse si dedicano al rapporto etero solo nel periodo fertile, i figli vengono accuditi da lesbiche e i maschi si concedono ad affettività gay. Anche i comportamenti trans sono frequentissimi. Senza scomodare i cambi di sesso spontanei nei pesci o l’ermafroditismo di molte specie, basta chiedere ai contadini, nei cui pollai ogni tanto un gallo si rifiuta di montare le femmine, non canta e cerca uova da covare, e le galline provano a inseminare.
A suo tempo l’onorevole Vladimiro Guadagno, in arte Luxuria, è stata colta dalla collega Elisabetta Gardini nella toilette parlamentare femminile. Ma in quale bagno deve andare una persona trans?
Davide. Da quando un guardiano della stazione mi buttò fuori dai bagni delle donne a 14 anni, ho cominciato ad andare in quelli degli uomini: per me è stato un riconoscimento della mia identità maschile, fuori e dentro. Per qualcuno i bagni unisex sarebbero più «politically correct», contrarie ai quali sono le donne perché «gli uomini sporcano di più». Credo che pulizie più frequenti siano la soluzione, come anche togliere le targhette dalle porte: quando una persona in transizione è costretta a scegliere, mette comunque in imbarazzo qualcuno.
Mirella. La direzione del mio ufficio alle Poste predispose un bagno solo per me, un’operazione di cortesia che rappresentava l’imbarazzo della dirigenza: modi gentili per separarti dagli altri attraverso il «privilegio segregante». Ma se è davvero una questione d’igiene, facciamo bagni anche per chi è circonciso e per chi non lo è, visto che cambia il controllo sul getto d’urina. E non sa la Gardini quante donne fanno la pipì in piedi? Mamme, insegnate ai vostri figli maschi a fare la pipì in piedi nei boschi e nei vespasiani e seduti nelle tazze e nelle turche: non saranno meno virili, solo più puliti.
Omosessualità e transgenderismo come si rapportano?
Davide. L’omosessualità si riferisce all’orientamento sessuale, il transessualismo all’identità di genere. Il trans Ftm è psicologicamente uomo e, come qualsiasi uomo, può essere etero, omo o bisessuale. Prima della transizione ho frequentato lesbiche, scoprendo che venivo percepito come uomo creando destabilizzazione nella loro percezione di sé. Fisicamente ero donna, uomo nell’identità, e non avevo né desideravo rapporti con uomini. Ora ne amo uno e rifiuto il limite imposto alla mia sessualità: proprio in quanto trans sono costretto a essere me stesso il più fedelmente possibile.
Mirella. Fare in un colpo solo il doppio salto mortale di sovvertire identità e orientamento sessuale dominante è troppo. Spesso si confonde il modello che si aspira a diventare con l’oggetto dell’attrazione; quasi tutti, ai primi stadi della transizione, per condizionamento sono o diventano etero rispetto al sesso di elezione. Una volta superato questo limite decide l’orientamento affettivo: chi cerca l’amore complementare si rivela etero, chi lo cerca affine omosessuale, come me. E in genere le donne, pure le lesbiche più rigide nel rifiuto del maschio, mi percepiscono donna. Anch’io vittima del condizionamento, ho ritardato di decenni la transizione poiché non riuscivo a coniugare il mio sentirmi femmina con l’attrazione verso questo stesso sesso, e ho dovuto sperimentare veloci approcci con uomini per autorizzarmi a valere come donna. Ora, dopo cinque anni con una compagna e altri al femminile, posso dire con serenità di essere lesbica. Attualmente single, purtroppo.
L’intervento ai genitali è un passo necessario?
Davide. No. Non tutte le persone trans desiderano l’intervento, ma il tribunale condiziona la modifica anagrafica del sesso all’intervento di rettificazione dei genitali, sia pure la legge non lo richieda espressamente. Una volta avuta l’autorizzazione, dopo una lista di attesa per l’intervento a carico del Servizio sanitario nazionale, avviene l’operazione e il tribunale registra la rettifica. Chi non accetta di sottoporsi all’intervento affogherà in un limbo giuridico per tutta la vita.
Mirella. Il bisogno di intervento è condizionato dal fatto che lo Stato ci consegna documenti e indicativi di genere adeguati alla nostra realtà solo se ci sottoponiamo a tale procedura. Ciò è semplicemente aberrante. Noi Mtf siamo discriminate anche qui: agli Ftm il Servizio sanitario nazionale passa la mastectomia perché un uomo con il seno non esiste, mentre è a nostro carico il costo della rimozione della barba. Evidentemente le donne con la barba vanno bene.
Ha completato la transizione?
Davide. Sì, e transizionare mi ha insegnato che le differenze tra sessi non sono nette: esiste una sorta di individuo-base che non è né maschio né femmina.
Mirella. L’ho completata, ma per me non ha voluto dire operarmi ai genitali, bensì far circolare estrogeni nel mio cervello femminile. Se la transizione cambiasse solo il corpo e non rimuovesse gli effetti del testosterone nella psiche servirebbe a poco, lo scopo è trovare un equilibrio.
Passare nel corpo di un uomo e di una donna può aiutare a comprendere le differenze tra i sessi?
Davide. Tra i nativi americani le persone transgender erano considerate un tramite naturale tra sessi e, perciò, dotate di innata saggezza. Se riconoscessimo le diversità come ricchezze scopriremmo che le persone trans non sono un peso ma una forza motrice, la cui sola esistenza dimostra che tra il maschile e il femminile c’è un continuum, non un confine netto. La transizione è un passaggio, non un abbandono totale di una vita per approdare a un’altra: non cambiamo identità ma adeguiamo il corpo, mezzo d’espressione che influenza la personalità al pari dell’essere bassi o alti.
Mirella. Siamo state spie nel mondo maschile, come gli Ftm lo sono stati nel mondo femminile.
È più facile la transizione per un Ftm o per un Mtf?
Davide. In una società patriarcale passare dal sesso femminile al maschile è visto come un avanzamento nella scala sociale. Gli atteggiamenti maschili in chi è nato donna sono maggiormente tollerati e un Ftm, al pari di una donna mascolina, può vivere nel limbo tra i sessi. Tollerato ma oppresso: gli Ftm nella storia non sono quasi mai riconosciuti tali. Allevati come femmine, se si vestono da maschi non destano scalpore. E i forti effetti del testosterone cancellano ogni traccia di ambiguità.
Mirella. La condizione transgender mette in luce il maschilismo: tradire il «privilegio» è imperdonabile. Mio padre, che per due anni si è rifiutato anche di parlarmi al telefono, un giorno disse a mia madre che se mia sorella avesse sentito di diventare uomo, avrebbe capito, ma io, io che ero uomo… no.
Maschilismo o femminismo?
Davide. Man mano che studiavo i capisaldi del femminismo e venivano a galla tutti i torti degli uomini, mi sentivo inconsciamente in colpa in quanto maschio (sia pure non ancora nel corpo) e mi sentivo un traditore. Stai scegliendo la strada più facile, mi dicevo, l’unico modo per rimediare alle umiliazioni subite dalle donne è che siano le stesse a ribellarsi: quindi, se vuoi fare qualcosa per loro, devi farlo da donna! È stata la mia crisi più tremenda. Ho capito che gli Ftm devono molto ai movimenti di liberazione della donna e omosessuale, ma ho abbandonato il collettivo ritenendo giusto che le donne se la cavassero da sole.
Mirella. Noi Mtf siamo già parte del movimento femminista. I movimenti transfemminista e translesbico in Italia sono ai primi passi, ma in paesi più evoluti stanno contribuendo a scrivere nuove pagine su un’identità femminile liberata dall’influenza dell’educazione alla sottomissione e un’identità lesbica che sappia esistere in modo non subalterno al maschile dominante. In Danimarca, il Partito femminista ha acquisito una leadership transgender-femminista e una politica più radicale contro la società maschilista. Gli Ftm, dal canto loro, hanno l’occasione per far nascere «l’uomo nuovo», liberato dai condizionamenti di un maschilismo violento contro le donne, ma contemporaneamente anche una stretta gabbia per gli uomini stessi.
Problemi sul lavoro?
Davide. Sì, tanti, specie per le ragazze. Ben Barres, neurobiologo e docente di neurologia e scienze neurologiche, è un transgender da donna a uomo. Recentemente ha denunciato il fatto che la sua vita come ricercatore è cambiata dopo la transizione. Quando era giovane fu, come donna, scoraggiata a frequentare il Mit (Massachusetts Institute of Technology) nonostante i risultati eccezionali conseguiti. E racconta che nel 1997, quando iniziò la sua vita al maschile, dovette sentire un collega dire a un altro: «Ben Barres ha tenuto un grande seminario oggi; certo il suo lavoro è molto migliore di quello della sorella». Ovviamente non esiste nessuna sorella di Ben, ma Ben prima della transizione. Superiorità genetica? No, maschilismo. Personalmente, non ho avuto problemi sul lavoro. Conta l’informazione, come quella predisposta in un opuscolo Crisalide-Cgil che spiega come gestire il rapporto persona trans/colleghi, le regole sulla privacy, l’utilizzo dei bagni, i permessi per gli interventi.
Mirella. I problemi sul lavoro sono infiniti. Io, come il 99 per cento delle neodonne. Trovare con documenti difformi un lavoro diverso da quello del lavascale è quasi impossibile. Sono grata alle agenzie di pulizia che guardano al lavoro svolto e non a cosa c’è fra le gambe. Tutti gli altri settori ci sono preclusi. Quando ho iniziato la transizione non potevano licenziarmi, ma ho subito tre anni di mobbing pesantissimo e ne sono uscita solo grazie all’intervento dell’unica dirigente donna dell’ufficio. Oggi sono invalida civile al 100 per cento per un aneurisma all’aorta causato dall’ipertensione di quegli anni. Ci abbiamo rimesso io, l’azienda che ha perso una buona impiegata, lo Stato che deve pagarmi una miserrima pensione a soli 47 anni. Se avessimo la privacy sul nostro percorso, le aziende non saprebbero. Dirò di più: una trans è un ottimo investimento perché, discriminata ovunque, scarica sul lavoro la voglia di rivincita.
Cosa chiedereste al governo?
Davide.Una legge all’inglese per il cambio di genere e nome a prescindere dall’intervento sui genitali e che non passi attraverso un giudice dove la persona transgender ha come controparte lo Stato. La copertura delle spese della transizione da parte del ministero della Salute. Una legge che recepisca in toto la direttiva europea secondo cui le norme per le pari opportunità si applichino anche a chi transizioni da un sesso all’altro o intenda farlo. Il tutto da aggiungersi alle revisioni in via d’approvazione della legge Mancino, che ha aggiunto orientamento sessuale e identità di genere fra le aggravanti dei reati per odio e pregiudizio, e della norma sul diritto di asilo che ha esteso a gay e trans il diritto di rifugiarsi in Italia da paesi dove essi sono puniti legalmente o attraverso gli squadroni della morte.
Mirella. Un’azione positiva sulla prostituzione transessuale, per molte Mtf unica possibilità di sopravvivenza a una famiglia che le ha abbandonate e a una società che non ha offerto il minimo spiraglio lavorativo. Quindi, i Pacs. Ho presentato una lettera al ministro per le Pari opportunità Barbara Pollastrini nella quale rilevo una falla nella legge 164 che regola il cambio di sesso; con soddisfazione constato che l’onorevole Luxuria ha fatto proprie queste osservazioni per ottenere una legge che preveda l’automatismo tra rettifica del sesso e cambio del nome anagrafico senza l’obbligo di chirurgia genitale. L’anomalia: in Italia sono vietati i matrimoni gay, ma una trans può chiedere l’autorizzazione all’intervento, poi non procedere alla seconda istanza di rettificazione anagrafica e, nel corpo di una donna ma ancora uomo sui documenti, realizzare un matrimonio lesbico autorizzato dallo Stato. Di fatto, posso sposare una lesbica. E non è detto che non lo faccia. (ROMINA CIUFFA)

PANORAMA- Dicembre 2006